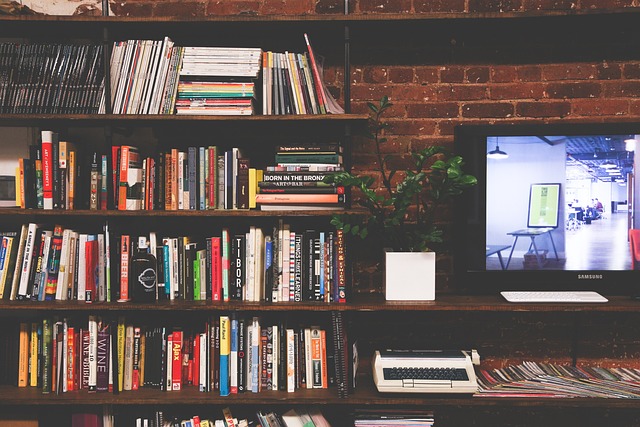I disturbi specifici dell’apprendimento comprendono un gruppo di condizioni classificate come disturbi dello sviluppo neurologico, che implicano una causa genetica.
I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono catalogati nel DSM-V come disturbi dello sviluppo neurologico; possono manifestarsi nell’ambito della lettura, della matematica e della scrittura e sono tipicamente chiamati dislessia, discalculia e disgrafia, rispettivamente.
Sono presenti in circa il 5-15% dei bambini in età scolare; il loro impatto non si limita all’ambito scolastico, ma si ripercuote in diversi settori connessi alla quotidianità, con conseguenza sulle opportunità lavorative ed educative delle persone.
I DSA sono caratterizzati da una componente genetica; studi empirici hanno dimostrato che nella condizione in cui uno dei genitori sia un DSA, il bambino ha un rischio aumentato che va dal 30 al 77% di manifestare tale condizione.
I DSA possono presentarsi in comorbilità con altri disturbi e condizioni; in tal senso, la comorbilità tra dislessia e discalculia è del 30-50%, mentre la comorbilità tra dislessia e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è, approssimativamente, del 25-50%.

Sebbene la comorbilità tra dislessia, disgrafia e discalculia non sia stata ancora completamente spiegata, è stato ipotizzato che possa essere riferibile a fattori comuni, come il deficit nelle abilità spaziali.
La manifestazione del DSA dipende dall’ambito coinvolto; nel caso della dislessia si manifesta attraverso una scarsa precisione nel riconoscimento delle parole, nell’ambito della discalculia le difficoltà riguardano il calcolo, nel caso delle difficoltà di scrittura si avranno errori ortografici e grammaticali.
Il DSM-V stabilisce che per l’identificazione dei DSA devono essere soddisfatti due criteri di inclusione e un criterio di esclusione; il primo criterio di inclusione richiede che le difficoltà siano verificate attraverso una bassa performance documentata in un test standardizzato.
Il secondo criterio di inclusione prevede che le difficoltà debbano persistere nonostante l’intervento educativo; tale punto appare rilevante, perché significa che, effettivamente, i DSA sono la conseguenza di un disturbo che riguarda una componente genetica.
Il criterio di esclusione implica che i DSA devono manifestarsi in assenza di deficit intellettivi, sensoriali ed educativi.
Ad ogni modo, affinché l’intervento possa essere efficace, esso deve essere diretto, esplicito e sostenuto nel tempo; in tal senso, il sostegno diretto deve ricomprendere istruzioni dirette.
In ambito scolastico, gli insegnanti devono disporre di informazioni complete in merito ai punti di forza e di debolezza del soggetto; in tal modo, sarà possibile progettare i supporti da offrire, privilegiando un approccio di lavoro incentrato sulla persona.
Non esistono metodi generali applicabili a tutti i bambini portatori di determinate condizioni, ma ogni bambino deve essere analizzato nella sua complessità.
FONTI
APA. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, (2013),
H. D’Souza, A. Karmiloff-Smith, Neurodevelopmental disorders, Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci., 8 (2017),
D. Gartland, R. Strosnider, Learning disabilities: Implications for policy regarding research and practice: A report by the National Joint Committee on learning disabilities, Learn Disabil Q., 41 (2018), pp. 195-199
R. Bosch, M. Pagerols, C. Rivas, L. Sixto, L. Bricollé, G. Español-Martín, et al, Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: prevalence and sociodemographic correlates, Psychol Med., (2021), pp. 1-11
SE NECESSITI DI SUPPORTO E ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DELLA TESI TFA SOSTEGNO CONTATTACI AL 045 8250212 320 5355319 377 4428200, OPPURE COMPILA IL FORM DI CONTATTO